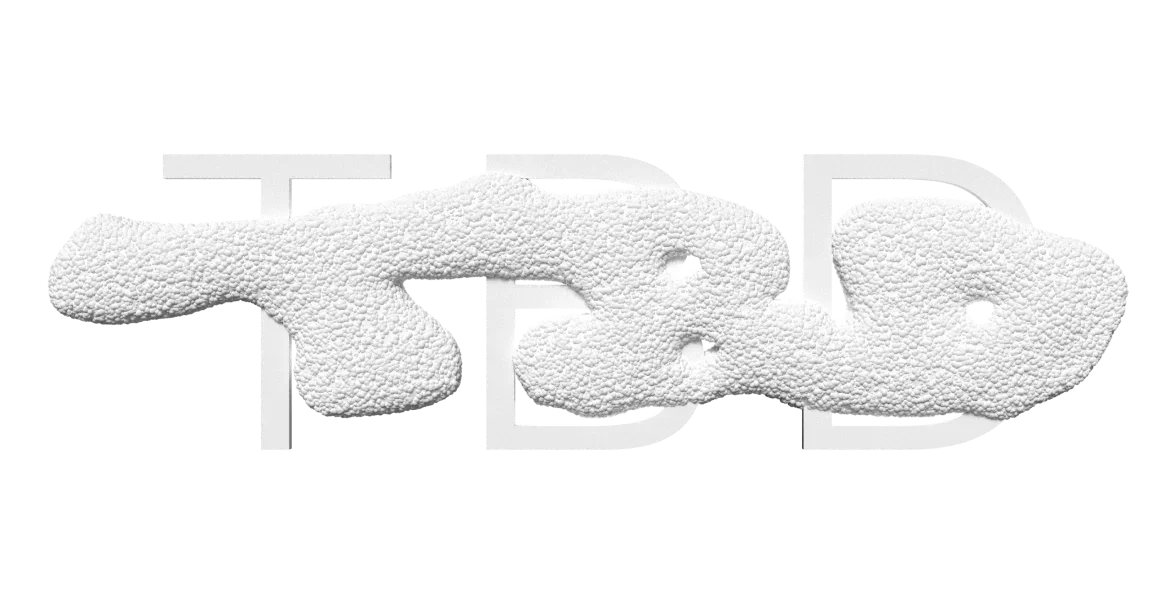❌ Call has closed
ISSUE 5: LAGNE - CALL FOR COMPLAINTS
(Eng version below) Dal Medioevo fino al ‘700, nelle repubbliche marinare di Venezia, Genova e Napoli, la pittima si aggirava nelle calli, sfiancando i debitori per conto terzi. Seguendo a breve distanza i malcapitati, li seppelliva tra lamenti, grida, strepiti e accuse lanciate nel mezzo dello spazio pubblico, servendosi della vergogna per costringerli a pagare il dovuto. Ancora oggi, la “pittima”, nel dialetto di alcune parti d’Italia, indica chi sfinisce i propri interlocutori a suon di lamentele. D’altro canto, fino alla prima metà del Novecento, le Attitadoras sarde e le prefiche lucane venivano pagate per presenziare alle veglie funebri piangendo e lodando i defunti, ricordandone le qualità, le virtù e creando l’impressione di grande trasporto e partecipazione collettivi. Figure opposte per intento ma accomunate da una certa professionalità della “lagna”, fanno tutte del lamento una pratica sociale, una forma di potere e di mediazione. Maschere del vernacolare italiano, i lamentatori “professionisti” esistono ancora oggi, portando avanti una lunga tradizione in molteplici forme. Chi tramite il Trauma Dumping – lo sfogo senza misura che scarica su altri le proprie frustrazioni – chi usando la lamentela come strumento di lotta, miccia essenziale della protesta politica. Il lamento ha assunto nel tempo una qualità altamente ambigua: segno di debolezza o di resistenza, infantilizzato o sovversivo, patologizzato o, addirittura, poetico. Sul piano culturale e coloniale, la lamentela è spesso relegata a una presunta “primitività” dei soggetti che la praticano, derubricata a espressione di un’emotività femminile, subalterna e incolta . Dal femminismo “guastafeste” al sindacalismo fantozziano, chi si lamenta è continuamente ridicolizzato o disinnescato da chi, al contrario, può permettersi il privilegio di abbracciare la retorica ottimistica della “resilienza obbligatoria” e del “tutto bene”. Ironicamente però, sono proprio i potenti a saper manipolare il dispositivo del lamento, ricalcandone i tratti in chiave grottesca per costruire nemici o grandi narrazioni, dalla “premier più odiata d’Italia” ai pigri facinorosi che, tutto sommato, dalla protesta non desiderano altro se non un “week-end lungo”. La cultura del lamento, tuttavia, ha radici profonde e stratificate. La storia offre un’ampia antologia di pratiche del lamento, inteso come codice collettivo e universale, in grado di trasformare la sofferenza in partecipazione. Reclamare attenzione, infatti, significa anche collettivizzare un dolore, inscriverlo in forme e rituali condivisi che vanno dalle liturgie popolari ai canti funebri, dai pianti rituali delle comunità mediterranee ai lamenti barocchi di Monteverdi. Nella Francia prerivoluzionaria, i Cahiers de doléances raccoglievano le rimostranze del popolo per dare forma a movimenti che portassero a nuovi ordini politici. In inglese, ancora oggi, il verbo “to complain” rimanda tanto al lamento quanto alla rivendicazione di un torto, e nella sua declinazione più formale - to file a complaint - al gesto del lamentarsi come concreta richiesta di giustizia. Alla radice del lamento si trova anche, forse soprattutto, il rumore, che genera rivolta. Tra corpi politici sempre più cooptati al rispettoso silenzio e a una rigida compostezza, il lamento appare più urgente che mai. Il pianto disperato, le grida di protesta o anche solo un sottile borbottare rispondono a un bisogno condiviso e impellente di rimarcare il proprio ruolo, che sfocia anche nel mondo delle immagini e dell’arte. Lagne - quinto numero di TBD - è dedicato alle pratiche e alle teorie del lamento. Cahier des doléances contemporaneo, Lagne traccia un prontuario della “buona lagna” in un presente in cui i motivi per lamentarsi si moltiplicano, mentre gli spazi per farlo si restringono. Essendo intrinsecamente collettivo, il lamento che TBD intende indagare con questo numero lo è altrettanto. Stiamo quindi cercando contributi di varia natura - testi critici, saggi visivi o altre proposte da discutere con la redazione - che indaghino temi quali: : Esperienze di lamentazione poetica, artistica e culturale.; - Artist* la cui lagna dia spazio al gioco (Patrizia Cavalli), a un doloroso sarcasmo (Cesare Pavese) o alle proteste di intere comunità (Adelita Husni-Bey); - Voci singole o collettive che, attraverso litanie di dolore o di scherno, raccontano il mondo contemporaneo; - Rapporto fra lamento e protesta politica; - Nuove visioni di questo rumoroso dispositivo antico applicato alle vicende della più stretta contemporaneità; - Archeologie del lamento tra pratiche rituali e schemi culturali; - Racconti, immagini e altri utilizzi del lamento tra culture e geografie diverse. Per i contributi è richiesto un abstract di 300-500 parole entro il 6 dicembre. Insieme agli abstract dovrà essere consegnata una biografia (250 parole), e, se necessaria, una breve bibliografia che rispetti le norme editoriali della rivista. Abstract (e contributi) possono essere inviati in italiano, inglese o spagnolo. In caso di esito positivo della selezione, i testi dovranno essere inviati, nella loro forma completa, per un massimo di 20 mila battute, entro il 15 febbraio 2026. La selezione delle candidature sarà comunicata entro il 13 dicembre 2025. Gli abstract andranno inviati a info@tbdultramagazine.com con oggetto “Lagne_Titolo Contributo_NomeAutore”. I contributi raccolti o i relativi estratti saranno pubblicati sul numero cartaceo dedicato e promossi sui canali social del magazine. /// From the Middle Ages until the 18th century, in the maritime republics of Venice, Genoa and Naples, the pittima roamed the streets, hounding debtors on behalf of third parties. Following the unfortunate victims at close range, the pittima would overwhelm them with lamentations, cries, clamour and accusations hurled in the middle of public spaces, using shame to force them to pay what they owed. Even today, in some parts of Italy, the word “pittima” refers to someone who exhausts their interlocutors with complaints. On the other hand, until the first half of the 20th century, Sardinian Attitadoras and Lucanian mourners were paid to attend funeral vigils, weeping and praising the deceased, recalling their qualities and virtues and creating the impression of great collective emotion and participation. Opposite figures in intent but united by a certain professionalism in their “lagna” (complaining), they all make lamentation a social practice, a form of power and mediation. Masks of the Italian vernacular, “professional” lamenters still exist today, carrying on a long tradition in many forms. Some use trauma dumping – the unrestrained venting of one’s frustrations on others – while others use lamentation as a tool of struggle, an essential fuse for political protest. Over time, lamentation has taken on a highly ambiguous quality: a sign of weakness or resistance, infantilised or subversive, pathologised or even poetic. On a cultural and colonial level, today, complaining is often relegated to a supposed “primitiveness” of those who practise it, dismissed as an expression of feminine, subordinate and uneducated emotionality (at least in the West). From “killjoy” feminism to trade unionism (typically represented by funny characters, such as the renowned Italian Fantozzi), those who complain are constantly ridiculed or defused by those who, on the contrary, can afford the privilege of embracing the optimistic rhetoric of “mandatory resilience” and “everything is fine”. Ironically, however, it is precisely the powerful who know how to manipulate the device of complaint, grotesquely exaggerating its features to construct enemies or grand narratives, for example by lamenting being the “most hated prime minister in Italy” or pointing the finger at others as lazy troublemakers who, all things considered, want nothing more from their protests than a “long weekend”. The culture of lamentation, however, has deep and layered roots. History offers a wide array of practices of lamentation, understood as a collective and universal code capable of transforming suffering into participation. Demanding attention, in fact, also means collectivising pain: inscribing it in shared forms and rituals ranging from popular liturgies to funeral songs, from the ritual weeping of Mediterranean communities to Monteverdi’s Baroque lamentations. In pre-revolutionary France, the Cahiers de doléances used to collect the grievances of the people to give shape to movements that would lead to new political orders. In English, even today, the verb “to complain” refers both to lamentation and to the assertion of a wrong, and in its more formal form, to file a complaint, to the act of complaining as a concrete request for justice. At the root of lamentation there is also, perhaps above all, noise, which generates revolt. With political bodies increasingly co-opted into respectful silence and rigid composure, lamentation seems more urgent than ever. Desperate cries, shouts of protest, or even just a subtle mutter respond to a shared, urgent need to emphasise one’s role, which also spills over into the world of images and art. Lagne – the fifth issue of TBD – is dedicated to the practices and theories of lamentation. A contemporary Cahier des doléances, Lagne outlines a handbook of “good lamentation” in a present where the reasons for complaining are multiplying, while the spaces for doing so are shrinking. Being intrinsically collective, the lamentation that TBD intends to investigate in this issue is equally so. We are therefore looking for complaints in the form of: - Experiences of poetic, artistic and cultural lamentation. Leading figures in subverting the increasingly powerful individualistic and silent narrative of today; - Artists in whom lamentation gives way to playfulness (Patrizia Cavalli), painful sarcasm (Cesare Pavese) or the protests of entire communities (Adelita Husni-Bey); - Individual or collective voices that, through litanies of pain or derision, recount the contemporary world; - New visions of this noisy ancient device are applied to the events of the most recent contemporary history; - Stories, images and other uses of lament far from the Western orbit. Contributions must be accompanied by a 300-500-word abstract submitted by 6 December 2025. Along with the abstract, a biography (250 words) and, if necessary, a brief bibliography complying with the journal’s editorial standards must be submitted. Abstracts (and contributions) can be submitted in Italian, English, or Spanish. If selected, the full texts, up to 20,000 characters each, must be submitted by 15 February 2026. The selection of candidates will be announced by 13 December 2025. Abstracts should be sent to info@tbdultramagazine.com with the subject line “Lagne_Title of Contribution_Author’s Name”. The contributions collected will be published in the dedicated print issue and promoted on the magazine’s social media channels.